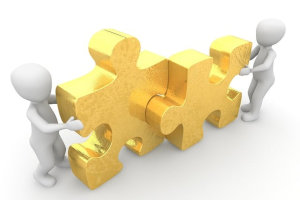Obbligo di utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico; erogazione di farmaci anche in locali diversi dalla farmacia; interventi in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche
Il Consiglio dei Ministri, con comunicato n. 75 del 26 marzo 2024, ha reso noto di aver approvato un disegno di legge in tema di “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Di seguito si riportano alcune delle misure di maggior rilievo introdotte con il suddetto disegno di legge.
Attività economiche, turistiche e della navigazione
Il Governo è intervenuto in materia di semplificazione delle attività economiche, turistiche e della navigazione, prevedendo in particolare:
- la riduzione da 12 a 6 mesi del termine per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi;
- la facoltà per i comuni di concedere in via temporanea alle strutture alberghiere parti delle strade pubbliche, per consentire il parcheggio e il carico-scarico di bagagli;
- lo snellimento dei procedimenti previsti dal Codice della navigazione per il contratto di arruolamento del comandante della nave, dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- l’eliminazione delle criticità delle norme fiscali volte a favorire la fusione tra fondazioni, stabilendo che il criterio per l'assegnazione del credito di imposta sia l'ordine temporale di stipula dell'atto pubblico di fusione.
Procedimenti amministrativi in favore dei cittadini
Con il medesimo provvedimento normativo, il Consiglio dei Ministri è altresì intervenuto per semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare, in materia di:
- circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;
- permesso di costruire su immobili vincolati;
- autorizzazioni all'inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e all'affido o dispersione delle ceneri;
- dichiarazione di assenza e morte presunta, dimezzando i termini per la dichiarazione del relativo status.
Istruzione
Ulteriore ambito d’intervento del disegno di legge è quello della parità scolastica. In particolare, il disegno di legge si occupa di introdurre un sistema di maggiore efficienza nei pagamenti dei contributi alle scuole paritarie, oltre a prevedere un meccanismo di verifica ex post della regolarità contributiva e fiscale delle stesse.
Viene inoltre limitata la possibilità, per le scuole paritarie, di attivare le classi terminali collaterali, limitandola ad una soltanto (ossia al massimo due anni in uno).
Sempre nella medesima direzione muove la previsione contenuta nel DDL secondo cui l'alunno potrà sostenere “nello stesso anno scolastico, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale, con una commissione di esame presieduta da un soggetto esterno all'istituzione scolastica”.
L’intervento normativo impone altresì l’obbligo di utilizzo, da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico; vengono inoltre semplificate le procedure di iscrizione degli alunni presso le scuole statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, che avverranno attraverso la nuova piattaforma unica "Famiglie e studenti".
Per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato nel loro ruolo di sostegno, il Governo ha previsto che “in occasione del conferimento delle supplenze annuali o temporanee il docente di sostegno possa essere confermato sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico con precedenza rispetto ad altri docenti a tempo determinato”.
Salute
In tema di salute, il Consiglio dei Ministri ha previsto la possibilità di erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia che riporteranno la denominazione di “farmacia dei servizi”, tra le prestazioni in questione rientrano in particolare:
- la dispensazione di dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- le prestazioni analitiche di prima istanza (test per glicemia, emoglobina, urine, etc.);
- la possibilità che i farmacisti, appositamente formati, possano somministrare tutti i vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni;
- la possibilità di effettuare i test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra;
- la possibilità di scegliere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con Servizio sanitario regionale.
Viene inoltre concessa la possibilità che due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, esercitino in comune i servizi sanitari, previa stipula del contratto di rete.
Sordocecità
Il DDL introduce infine misure in tema di sordocecità, apportando modifiche alla normativa sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, riconoscendo “la condizione di sordocecità a tutti coloro che manifestano durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, a prescindere dall'età di insorgenza”.
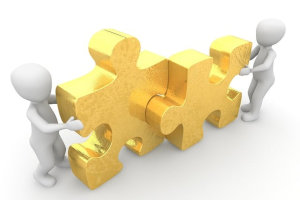
La Cassazione ricorda che il creditore che decide di stipulare una transazione parziale rinuncia in tal modo alla solidarietà passiva
Il sinistro e l’accordo transattivo parziale
Nel caso in esame, a seguito di un sinistro stradale, gli eredi del danneggiato aveva sottoscritto un atto di transazione con il danneggiante di carattere parziale. In ordine a tale circostanza il Giudice di merito aveva affermato che il condebitore solidale, estraneo alla transazione in esame, non poteva giovarsi degli effetti favorevoli della transazione parziale, non sussistendo la fattispecie di cui all’art. 1304 cod. civ., cioè che la transazione avesse ad oggetto l’intero debito.
In questo senso la Corte d’appello aveva detratto gli acconti già versati, nonché le somme versate in ragione della suddetta transazione, rideterminando la liquidazione il danno complessivamente da risarcire confermando gli esiti cui era giunto il Giudice di primo grado.
Avverso tale decisione aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione il condebitore estraneo alla transazione.
Gli effetti liberatori dei condebitori nelle transazioni parziali
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2426/2024, ha accolto, per quanto qui rileva, i motivi di ricorso proposti dal ricorrente.
In particolare, la Corte ha affermato che era pacifico il fatto che “la transazione conclusa dagli eredi della vittima fu soltanto parziale, con accettazione di una somma complessiva per tutti i familiari; dal ricorso si apprende (…) che in quell’occasione i transigenti riconobbero reciprocamente un concorso di responsabilità pari al 20 per cento a carico del conducente (..); ma, in fondo, quest’ultimo elemento è irrilevante, perché rispetto alla (condebitrice) oggi ricorrente quella transazione rimane una res inter alios, come tale del tutto priva della possibilità di influire sul successivo riparto delle responsabilità compiuto dalla Corte d’appello civile nella sentenza qui in esame”. Sulla scorta di tali presupposti, ha spiegato il Giudice di legittimità, la Corte d’appello aveva poi calcolato il debito residuo gravante sulla (condebitrice estranea alla transazione) (unitamente al proprietario e al conducente) detraendo dall’intera liquidazione le somme già percepite dai danneggiati a titolo di provvisionale e a titolo di transazione”.
La Corte ha evidenziato che tali conclusioni trovano fondamento normativo, negli artt. 1304 e 1311 c.c., che regolano gli effetti della transazione parziale. Nella specie, l’art. 1304, primo comma, c.c. dispone che la transazione “fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”. Occorre altresì precisare che tale norma si occupa unicamente della “transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti”.
Ne consegue, ha rilevato la Corte, che “poiché nel caso in esame la transazione era parziale, nessun margine di approfittamento poteva sussistere a favore degli altri debitori”.
Per quanto invece attiene all’art. 1311 c.c. esso stabilisce che la transazione parziale “ha come suo effetto tipico quello di sciogliere il vincolo della solidarietà tra i condebitori (…). La transazione parziale, infatti, è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne”. Sul punto la Corte ha proseguito il proprio esame rilevando che “D’altra parte, non potrebbe essere diversamente. Se, infatti, il creditore potesse transigere con uno dei debitori mantenendo il vincolo della solidarietà fra tutti, si determinerebbe l’effetto, palesemente irrazionale e ingiusto, di un suo possibile approfittamento in danno del debitore o dei debitori rimasti, ai quali potrebbe essere chiesto l’intero”.
Nei termini anzidetti, ha concluso la Suprema Corte, il Giudice di merito ha compiuto un errato calcolo delle somme da liquidare in quanto “non avrebbe potuto condannare (la condebitrice estranea alla transazione) (unitamente al proprietario e al conducente), (..), ma avrebbe dovuto, correttamente, condannare le parti suindicate (cioè i debitori rimasti) al pagamento della metà del danno complessivo, a prescindere dalla transazione, la quale andava a coprire la quota di responsabilità del conducente (..). E nessuna influenza poteva avere, ai fini di una diversa decisione, il fatto che gli eredi (…) avessero accettato, in sede di transazione parziale, un risarcimento rivelatosi poi inferiore alla metà del danno complessivamente liquidato”
Quanto appena riferito, ha riferito la Corte è anche confermato dalla regola secondo cui “il creditore che decide di stipulare una transazione parziale deve essere consapevole che in tal modo rinuncia alla solidarietà; per cui, se, come nel caso in esame, all’esito del definitivo accertamento le quote di responsabilità dei due debitori (originariamente) solidali risultano uguali, egli non può esigere dal debitore rimasto altri che la metà del danno complessivamente liquidato dal giudice, indipendentemente dalla somma concordata in sede transattiva”.

Il Governo ha approvato, in esame preliminare, un decreto di adeguamento della disciplina sanzionatoria in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Con comunicato stampa n. 73 dell’11.03.2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato in esame preliminare, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, un decreto legislativo “di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi”.
Prevenzione della diffusione illegale del Fentanyl e dei suoi derivati
L’approvazione del decreto legislativo di cui si è dato sopra conto, è stata preceduta dall’informativa presentata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio al Consiglio dei Ministri in relazione al “Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici”, elaborato dal Dipartimento per le politiche antidroga con il supporto dei Ministeri dell’interno, della salute e della giustizia.
Il documento in questione è stato elaborato tenendo in considerazione “l’obiettivo di definire le attività di prevenzione per intercettare e impedire l’accesso e la diffusione illegale in Italia del Fentanyl e dei suoi analoghi o la sua diversione per usi non sanitari, nonché la gestione di una ipotetica emergenza”.
Nel Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici, si legge che “Il fentanyl (o fentanil o fentanile) è un potente oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico. Come analgesico, ha effetti simili a quelli della morfina, ma è da 50 a 100 volte più potente di quest’ultima e 30-50 volte più potente dell’eroina”.
Nel sopracitato Piano viene altresì riferito che “Con decreto del 30 giugno 2020, in vigore dal 28 luglio 2020, i derivati del fentanyl sono stati inseriti nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309/90), analogamente al fentanyl che era già stato tabellato”.
L’intervento del Governo
Con il sopracitato Comunicato stampa, il Consiglio dei Ministri ha rappresentato che “In considerazione dell’inserimento dei medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina nell’elenco delle sostanze per le quali vige l’obbligo di autorizzazione all’esportazione per ogni singola spedizione da parte degli Stati membri verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa, le nuove norme estendono le sanzioni penali vigenti anche alle ipotesi di esportazione di tali sostanze verso Paesi extra UE non autorizzate dalla competente Autorità italiana (Ufficio Centrale Stupefacenti)”.
In ragione di tali circostanze, il Governo ha dunque dato avvio all’iter volto all’adozione di un decreto legislativo che si occupi dell’adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (decreto legislativo – esame preliminare).

Le Sezioni Unite ammettono la possibilità di costituire servitù di parcheggio su fondo altrui purchè sia attribuito un vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione
L’utilità della servitù di parcheggio
La vicenda prende avvio dalla decisione emessa dalla Corte d’appello di Venezia con cui veniva confermata la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della domanda di nullità della servitù di parcheggio temporaneo, transito e manovra di automezzi in genere. Sul punto il Giudice di secondo grado aveva in particolare rilevato come l’appellante non avesse “dato adeguata prova della carenza di utilità della servitù, utilità che invece è data proprio dalla possibilità di fornire piazzali adeguati alla azienda (…) essa, quindi, consiste nel più comodo sfruttamento del fondo dominante a vocazione industriale, e può concretizzarsi anche in maggiore amenità e comodità”.
Avverso tale decisione la parte interessata alla dichiarazione di nullità della servitù di parcheggio aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle servitù di parcheggio
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 3925/2024, prima di pronunciarsi in ordine alla specifica questione oggetto del ricorso sottoposto alla sua attenzione, ha ripercorso gli orientamenti interpretativi formatesi in ordine all’ammissibilità o meno delle servitù di parcheggio.
A tal proposito, la Corte ha ricordato un primo orientamento formatosi a partire dal 2004, secondo cui “il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla cosiddetta "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso, mentre la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietar”.
In contrapposizione alla suddetta interpretazione, la Corte ha fatto riferimento alla prevalente dottrina che si era invece espressa favorevolmente alla costituzione di servitù di parcheggio. Tale orientamento, ha evidenziato la Corte, aveva costantemente “osservato che nell’ipotesi di costituzione di servitù di parcheggio, la facoltà di parcheggiare l’auto sul fondo servente è certamente idonea ad arrecare una utilità al singolo, ma allo stesso tempo arreca un vantaggio per il fondo dominante rendendolo maggiormente utilizzabile”. Rispetto a tali servitù, ha spiegato la dottrina, oltre ai consueti requisiti richiesti dalla legge, è anche necessario che la servitù soddisfi “un’utilità specifica e quindi deve costituire un vantaggio diretto per il fondo dominante, uno strumento per migliorare l’utilizzazione di quest’ultimo”.
Dopo aver approfondito i contrapposti orientamenti, le Sezioni Unite hanno messo in luce come la questione “si pone quindi non già in termini di configurabilità in astratto della servitù di parcheggio, ma di previsione, in concreto, di un vantaggio a favore di un fondo cui corrisponda una limitazione a carico di un altro fondo, come rimodulazione dello statuto proprietario, a carattere tendenzialmente perpetuo”.
L’ammissibilità delle servitù di parcheggio
Posto i suddetti orientamenti interpretativi, le Sezioni Unite hanno dichiarato di voler aderire alla tesi favorevole alla costituzione delle servitù di parcheggio. A tal proposito, la Corte ha affermato che “La tesi favorevole alla costituzione della servitù, oltre ad essere in linea con il sistema, esalta in definitiva il fondamentale principio dell’autonomia negoziale (art. 1322 cc) che, si badi bene, non sfocia in una libertà illimitata, dovendosi sempre confrontare con il limite della meritevolezza di tutela degli elementi dell’accordo”.
Oltre a tali elementi, ha messo in rilievo la Corte, devono essere anche rispettati gli ulteriori requisiti dello “ius in re aliena quali l'altruità della cosa, l'assolutezza, l'immediatezza (..), l'inerenza al fondo servente (..) l'inerenza al fondo dominante (..) la specificità dell'utilità riservata, la localizzazione intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell’oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà”.
Al termine del proprio esame e nel dirimere il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, le Sezioni Unite hanno quindi riaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di servitù, lo schema previsto dall’art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù avente ad oggetto il parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all’esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti essere stata attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sempre che sussistano i requisiti del diritto reale e in particolare la localizzazione”.
La Corte ha poi concluso il proprio esame in ordine ai diversi motivi d’impugnazione proposti dal ricorrente, accogliendo il primo ed il terzo e dichiarando assorbiti i restanti.

Accertamento della violazione degli arresti domiciliari di non lieve entità in base alle circostanze del caso concreto
Aggravamento degli arresti domiciliari
Nel caso in esame, il Tribunale del riesame di Milano aveva confermato l’ordinanza della Corte di appello con cui veniva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari nei confronti del destinatario della stessa, con conseguente ripristino della custodia in carcere, posto che il condannato si era reso responsabile della condotta di evasione rispetto agli arresti domiciliari.
In particolare, l’odierno ricorrente era stato sorpreso nella pubblica via, dopo che si era incontrato con altra persona che deteneva sostanze stupefacenti. Dopo essere stato sorpreso dalle forze dell’ordine, il ricorrente si era poi dato alla fuga e, dopo un breve inseguimento, veniva fermato dalle stesse.
Avverso la decisione di aggravamento della misura disposta dal Tribunale, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Valorizzazione delle circostanze della violazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8630/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Tra i motivi di ricorso, il ricorrente ha lamentato mancanza di motivazione e violazione di legge della decisione adotta dalla Corte d’appello (confermata poi dal Tribunale del riesame) nella parte in cui, nel disporre l’aggravamento della misura a carico del ricorrente, il Giudice aveva erroneamente ritenuto che allo stesso fosse stato contestato il reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/90, mentre, ha evidenziato il ricorrente, tale fattispecie delittuosa, come emerge dalla narrativa dei fatti, poteva al più ipotizzarsi a carico del soggetto con cui il ricorrente si era incontrato.
La Corte ha dichiarato tale motivo manifestamente infondato, evidenziando che “il Tribunale del riesame ha correttamente dato atto che al ricorrente non è stato contestato il reato di cui all’art. 73, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma solo quello di cui all’art. 385 cod. pen., ritenendo che ciò non infici la decisione di disporre l’aggravamento della misura cautelare”.
Sul punto la Corte ha messo in evidenza che l’ordinanza aveva valorizzato un altro aspetto, ovvero il fatto che il ricorrente, non solo aveva violato la misura degli arresti domiciliari, ma era stato anche “sorpreso nell’attendere un soggetto, con il quale si incontrava fugacemente, risultato dedito allo spaccio di stupefacenti, ritenendo tale circostanza ulteriormente dimostrativa dell’insensibilità del ricorrente al rispetto delle prescrizioni insite nella misura cautelare cui era sottoposto”.
In relazione a tale situazione, la Corte, poste le circostanze complessivamente accertate, ha rilevato come il Tribunale avesse correttamente escluso che la violazione potesse considerarsi lieve.
Rispetto alle stesse, non è stata ritenuta attendibile la tesi sostenuta dalla difesa secondo cui il ricorrente, al momento in cui era stato fermato dalle forze dell’ordine, stava facendo ritorno presso la propria abitazione dopo essersi recato dagli assistenti sociali dai quali era stato autorizzato ad andare.
Tale tesi, spiega la Corte, non è stata accolta dal Tribunale dal momento che l’incontro in questione era avvenuto durante un orario incompatibile con quello in cui veniva constata la presenza del ricorrente al di fuori della propria abitazione. A tale elemento, la Corte ha rilevato come debba sommarsi anche il fatto che il ricorrente si era incontrato con un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti, configurando così una circostanza che contribuisce ad escludere, ai fini dell’aggravamento della misura, la lievità del fatto.
Sulla scorta di quanto sopra la Corte ha dunque rigettato il ricorso e ha affermato, per quanto qui rileva, che in tema di misure cautelari personali, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenute di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dal ripristino della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.